Il teatro italiano nel XVII e XVIII secolo
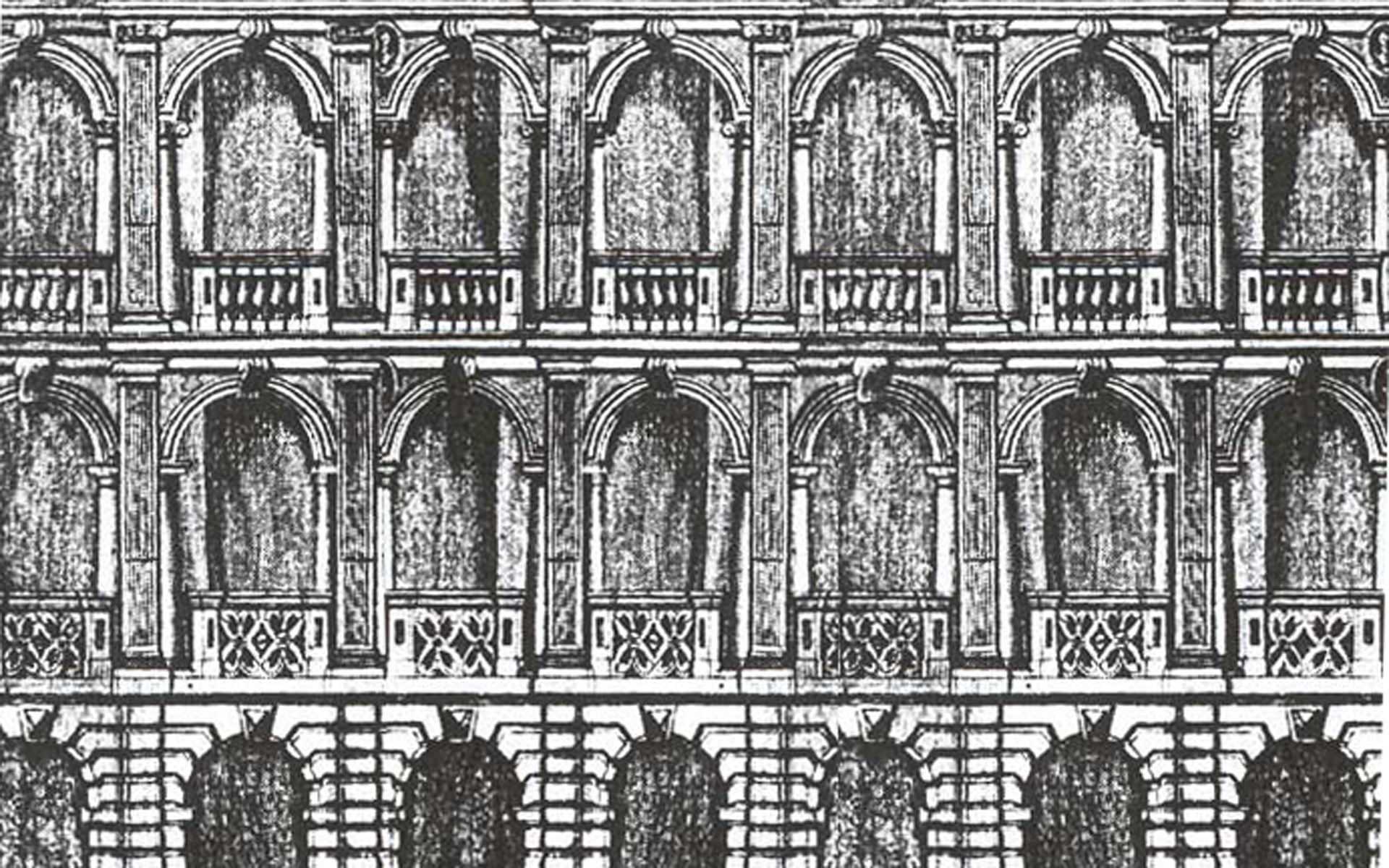

Nel XVII secolo la perdita di autonomia politica ed economica delle Signorie, entrate nell’area d’influenza di vasti Stati a struttura centralizzata, promosse l’ascesa e l’assunzione di responsabilità politico-amministrativa del patriziato, le cui fortune, spesso recenti, erano legate all’espansione di attività mercantili o speculative. La mutata stratificazione sociale si riflesse subito anche nelle forme del teatro dove si affermò, accanto o in sostituzione della sala di corte o d’accademia, la novità dei teatri aperti ad un pubblico pagante e oggetto di investimento da parte di imprenditori privati. Ancora sullo scorcio del Cinquecento, il fenomeno fece la sua prima comparsa, non a caso, in città mercantili come Venezia e Genova ma non tardò ad affermarsi anche altrove, come naturale conseguenza dell’impadronirsi delle istituzioni culturali da parte della classe detentrice del potere economico.
Lo spettacolo privato nel teatro di corte o nel chiuso delle Accademie non scomparve, ma subì esso stesso l’influenza delle forme in cui si sviluppò la rappresentazione teatrale aperta ad un pubblico più vasto ed eterogeneo.
[Per una panoramica sul teatro italiano si veda il saggio di G. Guccini, Introduzione, in Il Teatro italiano nel Settecento, Il Mulino, 1988, pp. 9-68]
Ai mutamenti nella composizione sociale degli spettatori si aggiunsero, in questo periodo, quelli dei nuovi “generi” di spettacolo che si stavano affermando. Sul finire del Cinquecento nacquero i primi elementi del melodramma, che sempre più si sostituì alla commedia ed alla tragedia d’imitazione.
La nuova forma drammatica reclamò, fin dalla sua prima comparsa, specifiche esigenze e modifiche dello spazio teatrale. Scriveva Emilio Cavaliere: ”La sala non deve contenere più di mille spettatori, comodamente seduti nel più profondo silenzio; gli ambienti più vasti sono sconsigliati perché hanno cattiva acustica e obbligano il cantore a forzare la voce uccidendo l’espressione; …l’orchestra sarà invisibile al pubblico, nascosta nel retroscena…” .
Sulla struttura del teatro incisero più profondamente fattori come la spinta al profitto, la composizione del pubblico, i nuovi riti sociali e lo stesso lento ma progressivo dissociarsi dello spettacolo dalla decadenza celebrativa e dal contesto festivo. La somma di questi fattori produsse un mutamento qualitativo nella storia dell’edificio teatrale. Va da sé che le soluzioni adottate per il melodramma si imposero anche per altre forme di spettacolo, come riflesso di una egemonia sancita dal costante favore del pubblico.
Il tipo teatrale barocco non partì comunque da zero. Del teatro da sala precedente sopravvisse il prospetto scenico, nella versione autoportante e architettonicamente qualificata, che era stata inaugurata nella sala farnesiana, con l’area profonda e meccanicizzata del palcoscenico, i cui ulteriori perfezionamenti tesero a divenire specialistica competenza dello scenografo, non sempre coincidente con l’architetto dell’edificio.
Nella platea, generalmente a forma di U o comunque a pianta allungata, si allinearono in forte pendio le file di panche riservate al pubblico più qualificato, mentre lo spazio antistante il proscenio venne occupato dagli orchestrali. Più ordini di logge sovrapposte, divisi da tramezzi radiali in tanti palchetti indipendenti, sostituirono, nel nuovo teatro, la cavea e i gradoni, dando alla sala un eccezionale sviluppo verticale e conferendogli il caratteristico aspetto “ad alveare” che contrassegnò per i secoli il teatro all’italiana.
La sala ad alveare cominciò a precisarsi col teatro di Bologna, dell’arch. A. Chenda del 1639, dove i palchetti vennero provvisti, nel retro, di accessi indipendenti.
La nuova tipologia ad alveare non si affermò comunque immediatamente in modo incontrastato. In una prima fase prevalsero ancora soluzioni miste che fondevano cavea a gradoni, logge e palchetti.
Le motivazioni economiche e funzionali del nuovo edificio ad alveare furono evidenti e si possono così riassumere: da una parte, con lo sviluppo in altezza della sala si ottenne la massima capienza, un fattore questo di primo piano in teatri che mirarono al profitto e dovettero sostenere ingenti spese per realizzare effetti spettacolari; d’altro canto, la suddivisione in palchetti, oltre a favorire un rapido flusso e deflusso degli spettatori, garantì la selezione sociale (alla lunga fu la zona dei palchetti migliori a divenire il settore del pubblico privilegiato!), e offrì una serie di occasioni speculative (affitto e subaffitto dei palchi).
La nuova sistemazione rispondeva a due requisiti che, in prospettiva, si sarebbero rilevati essenziali alla diffusione dei teatri: innanzi tutto, restaurava la separazione dell’aristocrazia all’interno di un contesto di fruizione pubblico; inoltre, lottizzando lo spazio della sala in tanti appezzamenti autonomi, schiudeva la possibilità ad una vasta gamma di soluzioni gestionali che andavano dal saltuario finanziamento delle stagioni o dei singoli spettacoli da parte dei palchettisti, alla comproprietà del teatro.
La sala a palchetti divenne così la sede naturale di una “rappresentazione” della vita sociale che rifletteva la stratificazione e l’ideologia della classe dominante. Il principe o le autorità, che pure conservavano una posizione eminente e privilegiata, non erano più gli unici ad essere contemporaneamente spettatori e oggetto di spettacolo; la cornice del palchetto inquadrava come un minuscolo arco scenico la rappresentazione del rito borghese del vedere e dell’essere visti, tendendo a sovrapporsi e quasi sempre a prevalere sull’azione centrale, suscitando la disapprovazione dei trattatisti del perido, fautori di un teatro morale e quindi anche di una “morale” dello stare a teatro.
I decenni che andarono dal primo apparire della sala ad alveare (1640 circa) fino a tutto il secolo successivo, videro il diffondersi del teatro all’italiana nei più importanti centri della penisola e d’Europa. Accanto ai nomi celebri, Juvarra, Fontana, Vanvitelli, si delineò una figura nuova di architetto specializzato che spesso riunì in sé la duplice competenza della costruzione della sala e dell’allestimento scenico. Tanti gli esempi: Gaspare Vigarini, Jacopo Torelli, le famiglie dei Bibiena e dei Mauro, che si tramandarono per generazioni una fama e un’esperienza riconosciute in tutta Europa.
Partendo dal collaudato schema della sala a palchetti, reputato insuperabile, la massima preoccupazione degli architetti di teatro divenne quella di conciliarne l’organicità strutturale con la necessità di attenuare il più possibile i difetti intrinseci all’organizzazione cellulare dello spazio, ossia di consentire le migliori condizioni visive ed acustiche a tutti gli spettatori, anche a quelli meno favoriti dalla posizione nei confronti del palcoscenico.
Questo sforzo, connesso alla ricerca dei materiali migliori, all’orientamento dei palchetti, alla curva del soffitto, all’illuminazione, trovò un suo momento di sintesi nella ricerca della pianta ottimale del teatro, che vide impegnati architetti e teorici in una disputa dove si intrecciarono argomentazioni estetiche ad esperimenti di fisica.
Va ricordato che esistette una sola costante nello schema planimetrico della sala all’italiana: quella di disporre l’asse maggiore perpendicolarmente alla fronte del proscenio, a differenza di quanto avvenne in Francia, dove prevalse la tendenza opposta.
1. PIANTA AD U
Già sperimentata nel teatro Farnese, la pianta ad U fu utilizzata nei primi teatri a palchetti ma venne presto sostituita da schemi mistilinei, che modificarono la curva di fondo; si vedano il teatro degli Intronati a Siena (1670), la sala degli Ottoboni a Roma di Juvarra (1708/12).
2. PIANTA A CAMPANA
Riproduce la sezione verticale di una campana con l’apertura corrispondente all’imboccatura della scena. Fu lo schema reso celebre dai Bibiena. Ferdinando, ritenuto l’inventore della veduta d’angolo, scrisse nel 1711 “L’architettura civile preparata sulla geometria e ridotta alla prospettive”, opera importantissima soprattutto per le visioni d’angolo, invenzione che rese celebri i Bibiena. Si trattava di applicare alla scenografia la prospettiva per angolo, dotata di due punti di fuga, che permetteva di rompere definitivamente con la monotona simmetria centrale che aveva dominato, durante quasi tutto il secolo XVII, in teatri come il Filarmonico di Verona (1729, Francesco Bibiena), il Comunale di Bologna (1756/63), lo scientifico di Mantova (1767/69) o il Quattro Cavalieri di Pavia (1771/73) progettati da Antonio. La pianta a campana venne criticata dall’Algarotti [F. Algarotti, Saggio sopra l’opera in musica, ed. Livorno, 1763] che nel suo saggio si prese gioco della vuota analogia di chi ne sosteneva l’intrinseca fonicità.
3. PIANTA ELLITTICA E OVOIDALE
Lo schema ad ellisse, meno frequente, fu quello che poté vantare, oltre alla preferenza dell’Algarotti, la difesa più diffusa ed argomentata “secondo i principi dell’ottica e dell’acustica”. Esempio ne è il Teatro Regio di Torino (1738), progettato da Juvarra.
4. PIANTA A FERRO DI CAVALLO
È con teatri come l’Argentina di Roma (1732) o la Sala di Vanvitelli nella Reggia di Caserta (1751/58) che lo schema planimetrico a ferro di cavallo trovò il definitivo equilibrio che ne impose l’adozione in tutti i teatri lirici edificati tra la fine del XVIII secolo e il XIX (Scala di Milano, la Fenice di Venezia, S. Carlo di Napoli).
Le ricerche di una planimetria ottimale andarono di pari passo con il processo di definizione dell’edificio teatrale, inteso ormai come organismo architettonico articolato, incentrato sull’invaso della sala ma provvisto in misura crescente di strutture di servizio e di rappresentanza.
La piena autonomia si raggiunse anche all’esterno dove la costruzione si affacciava isolata e con un volto architettonico riconoscibile, monumentale, fuoco urbanistico emergente ed espressione di prestigio economico e culturale della città. La facciata trovò una sua caratterizzazione tipologica solo in epoca neoclassica e si fregiò generalmente di un ordine di paraste o di colonne, concluso da un frontone triangolare.
Negli edifici più prestigiosi, fulcro del prospetto era quasi sempre un ampio porticato, talvolta emergente dal corpo dell’edificio, che era adibito allo scorrimento delle carrozze e a dar riparo all’ingresso principale. Tali entrate confluivano solitamente in un atrio da cui si diramavano le rampe di scale che conducevano ai diversi ordini. L’interno, ricco di addobbi e impreziosito dal gioco di luci, specchi e dorature, faceva da contraltare alla relativa severità dell’esterno, esaltando il carattere festoso, effimero e artificiale dello spettacolo di mondanità. Per buona parte del Settecento la cura dell’arredo dei palchetti venne affidata addirittura ai singoli affittuari, che facevano a gara nel manifestare i propri gusti e la propria condizione sociale in una sorta di estrema privatizzazione dell’atto pubblico, caratterizzata dalla nascente civiltà borghese. Fu in quest’epoca che il palco divenne un’appendice privata del palazzo signorile, spesso munito di retropalco, vestiboli o séparés, dove era possibile ricevere, conversare, giocare a carte, consumare spuntini in un ambiente intimo e, in ultima analisi, vedere lo spettacolo.
Ciò non toglie che anche l’arredo e le decorazioni della sala dovessero rispettare quei criteri di massima visibilità che si richiedevano all’ambiente teatrale.
I Bibiena, fautori della “fonicità” della pianta a campana, introdussero in alcuni teatri (Verona) un falso soffitto in legno traforato che moltiplicava la sonorità dell’invaso, simile ad una cassa armonica.
A differenza delle altre strutture del teatro, l’area scenica non subì, tra Seicento e Settecento variazioni sostanziali ma piuttosto un ampliamento delle aree di servizio e una precisazione dei singoli elementi tipologici. Ai lati del piano di scena, nella zona invisibile agli spettatori, vennero dislocati i camerini degli attori, per lo più in piani sovrapposti, disimpegnati da scale e da ballatoi.
L’assenza di novità nell’area della rappresentazione non deve stupire, se si pensa che nulla era fondamentalmente mutato nella tecnica scenografica. Anche le spettacolari scenografie di Torelli, di Juvarra, dei Bibiena, e la stessa “prospettiva d’angolo” attribuita a Ferdinando Bibiena, se offrirono agli spettatori l’immagine sbalorditiva di spazi sconfinati e labirintici, non intaccarono la meccanica scenotecnica messa a punto dai loro predecessori e sperimentata da una pratica ormai secolare.
Il teatro, come ogni altro settore della vita sociale e culturale, passò al vaglio della critica illuministica che ne propose una riforma radicale alla luce dei nuovi principi di utilità pubblica, di moralità e di razionalità. Critica che, oltre a toccare l’aspetto letterario, musicale e spettacolare non trascurò la forma architettonica dell’edificio, sottoposta ad una revisione lucida e serrata.
La condanna più vibrata era comunque riservata ai palchetti, nei quali sembravano comprendersi [F. Milizia, “Trattato completo, formale e materiale del teatro”, Venezia, 1794] tutti i difetti e l’irrazionalità del teatro contemporaneo: “Questi palchetti, cioè questa molteplicità di fori e di tramezzi, tagliano in mille guise l’aria sonora, la riverberano in infiniti variissimi sensi, e la debbono per necessità confondere; onde nasce l’indispensabile effetto di sentir poco e male…Quanto questi palchetti sieno incomodi per vedere le rappresentazioni sceniche, e tutto il teatro, non v’è bisogno di prova. Né questo gran difetto si toglie con lasciare i tramezzi laterali fino a mezza vita, o col levarli affatto: si scema così in qualche maniera, ma non si estirpa, specialmente in quelli degli ordini superiori, di dove il palco si vede nel modo più disagiato“.
Ma peggiori ancora dei mali “fisici”, prodotti dai palchetti, erano i mali morali: “Quella comodità tanto decantata, che i palchetti forniscono di appiattirvisi e di starvi come invisibili, non è certo un’occasione conducente al buon costume”. Né giovava alla moralità dell’atto sociale la privata intimità del palchetto, che scoraggiava l’assunzione di un “bel contegno esteriore”, specchio ed esercizio di nobiltà interiore.
Ai palchetti il Milizia imputò perfino la decadenza artistica del teatro: ”E come può rappresentarsi un buon dramma, il quale richiede un’attenzione seguita dal principio al fine, se i nostri sig. teatranti altra attenzione non si danno, che di maneggiare i loro spioncini, per le osservazioni de’ loro astri, per saltare di palco in palco e per farsi vedere su e giù? Ora si tuffano, ora si perdono, indi ricompariscono; da un teatro passano fino ad un altro e vi ritornano, e girano perpetuamente, trinciando freddure, complimenti, amoretti”. Se dunque la “noia de’ cattivi drammi” produsse i palchetti, questi, con un circolo vizioso ne ingrandirono “l’insipidezza e l’assurdità”.
Nel corso del Settecento, lo sviluppo dell’area intermedia fra il palco e la scena fu promosso da diverse soluzioni spaziali e architettoniche, che si affiancarono, seppur con minor successo, all’ispessimento della struttura d’arcoscenico (che all’epoca veniva denominata proscenio, mentre l’accezione attuale di tale termine era ricoperta dal più generico “palco scenario”). Mentre a Venezia le proprietà, per ottenere un maggior numero di posti, inserirono fino a tre file di palchi paralleli su ciascun lato della scena, determinando così un ambiente in cui l’arcoscenico si riduceva a due sottili trabeature disposte ai lati dei palchi, altri teatri presentavano un palco fortemente allungato in direzione della sala. Pierre Patte, nel suo Saggio sull’architettura teatrale (1782), confrontò questo criticato espediente all’arcoscenico profondo, che sul finire del secolo appariva la più conveniente e organica risposta ai problemi della diffusione acustica:
“In alcune sale il palco scenico non è separato che per via di un semplice muro, di maniera che quando parla l’attore, ei si trova necessariamente in faccia alle prime quinte, e se non ha più che grande attenzione a tenersi continuamente verso la sponda del palco scenico, la voce di lui corre pericolo di perdersi in parte fra le prime tele delle decorazioni. Si è a questo difetto rimediato in parecchie sale … portando in fuori nella sala il palco scenico; ciò pare però un isolar troppo l’attore in mezzo agli spettatori, e far torto all’illusione teatrale. Per evitare tai due inconvenienti si è ricorso al pensiero di un proscenio, il quale è come un luogo misto tra la sala e il palco scenico, destinato a preparare l’apertura di questo ultimo.”
In ogni caso, l’animata presenza degli attori doveva rendere ancora più evidente la centralità del proscenio architettonico che costituì un essenziale elemento di raccordo fra la scena e la sala e, ancor più, il fulcro dell’articolazione degli spazi teatrali. I teatri erano divisibili in tre zone, connotate da una precisa funzione: l’auditorium doveva contenere gli spettatori, il proscenio i cantanti e il palco scenico le scenografie. Per quanto riguarda gli scenografi, osserviamo che le prospettive per angolo dei Bibiena e le soluzioni pittoriche del barocchetto risposero anche all’esigenza di giustificare lo spazio avanzato e circoscritto dell’azione. Grazie alle nuove tipologie figurative, il palco scenico acquisì infatti valore di quadro e, non potendola ovviamente contenere, avvolse visivamente l’area di proscenio, entro contesti architettonici e sfondi paesaggistici abilmente raccordati dai laterali.
In quanto luogo neutro e giustapposto alle scenografie, il proscenio fu l’equivalente architettonico delle arie nelle opere.
Nel corso del Settecento, i teatri aumentarono enormemente di numero, trasformandosi da magnifico e raro connotato della grandezza di un principe, o d’una famiglia nobile, in istituto di vita civile. Sempre Milizia, nella seconda metà del secolo, osservava che il teatro era divenuto una necessità sociale e che “quella città che n’è priva, è riputata una ben meschina città”.
E’ importante però rilevare che, alla diffusione dei teatri non corrispose un proporzionale aumento demografico, né un massiccio fenomeno d’inurbamento, né uno sviluppo economico tale da costituire una forte e numerosa borghesia. Si è accennato come Pavia, proprio nel periodo dell’erezione del teatro, non versasse in ottime condizioni; tale era infatti la disperazione e misere le condizioni di vita che pareva impossibile per una città così ridotta dar vita a quelle opere che ancora oggi l’abbelliscono, quali sono il Teatro stesso, il Palazzo Mezzabarba e il Palazzo Bellisomi.
Il contesto economico corrispondente alla diffusione dei teatri, non individuò un’aumentata possibilità di introiti o un’effettiva vivacità di mercato, ma l’enorme capacità di spesa dimostrata dai nobili e dai notabili dei grandi come dei piccoli centri, che finanziarono collettivamente le realizzazioni sceniche, sia versando somme convenute o variabili alle proprietà, sia costituendo dei gruppi di “cavalieri associati” che commissionarono direttamente la costruzione di nuovi teatri, portando così alla luce l’organizzazione economica latente nel sistema dell’affittanza e della vendita dei palchi. In Italia i teatri pubblici si organizzarono come società azionarie a forte rischio e produssero lavoro, movimenti di denaro e ricchezze collaterali, a misura della capacità d’investimento dei loro soci.
Dalla stretta connessione fra la produzione operistica e la grande aristocrazia urbana o i Consigli municipali, nasceva la reticenza a chiedere dei prezzi d’ingresso proporzionali alle spese sostenute, che sarebbero stati interpretati come segno di un venale interessamento al guadagno in quegli stessi strati sociali per cui, d’altra parte, era qualificante ed essenziale poter rivestire in pubblico una funzione di mecenate. Di qui, la presenza di un pubblico popolare anche ai costosi allestimenti dell’opera seria.

